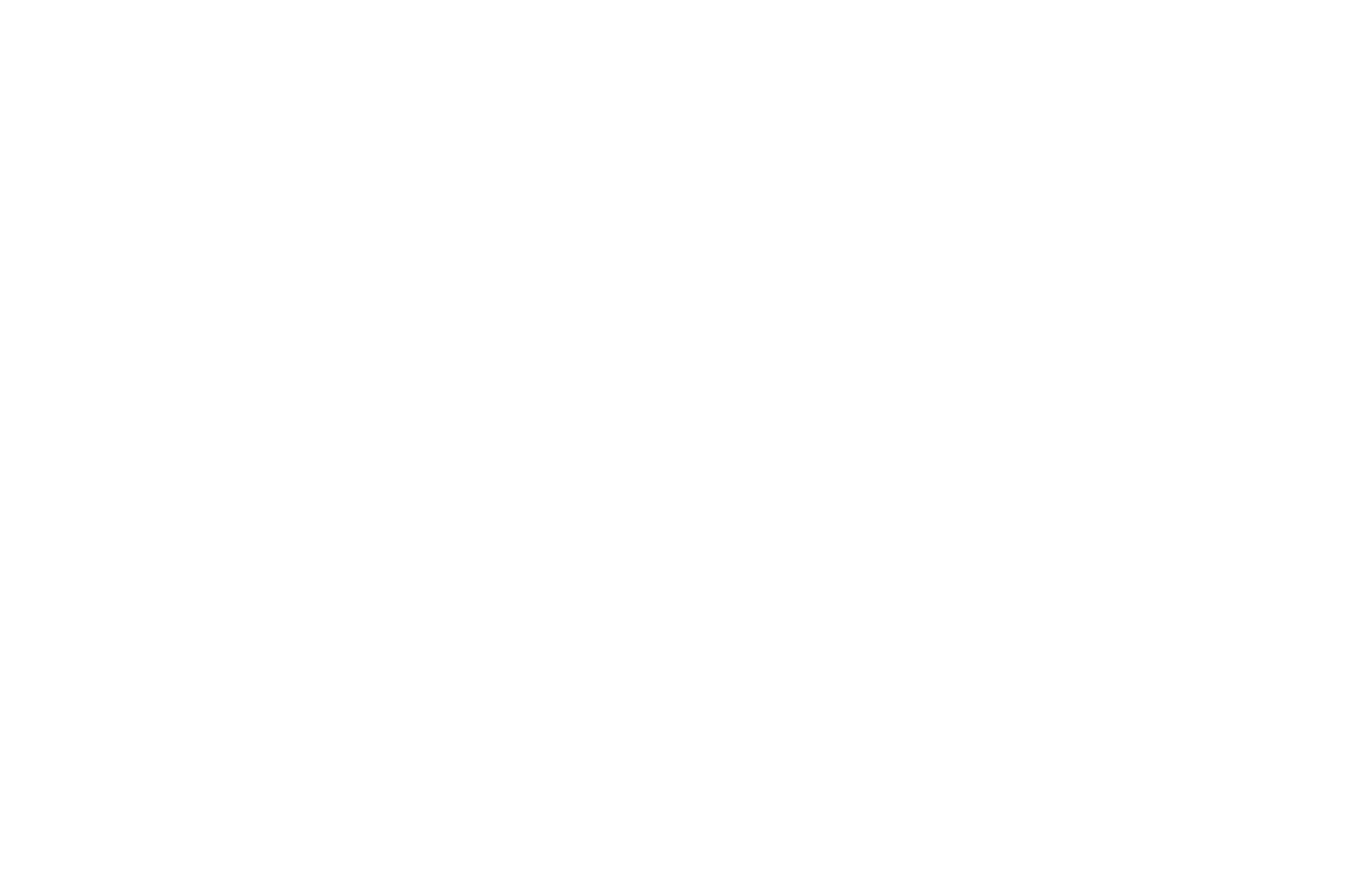«IN CHORO ET ORGANO». I SUONI DELLA CATTEDRALE (2025) – IX edizione
In nome del Princeps musicae: musica sacra di Giovanni Pierluigi da Palestrina
Sabato 24 Maggio 2025 – ore 21:00
Chiesa di San Donnino
Ingresso libero
In nome del Princeps musicae: musica sacra di Giovanni Pierluigi da Palestrina
Coro Concentus Vocum
Organista Luca ratti
Direttore Michelangelo Gabbrielli
La ricorrenza del Quinto Centenario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (Palestrina, 1525 – Roma 2 febbraio 1594) offre l’occasione di dedicare la IX edizione di «In choro et organo. I Suoni della Cattedrale» a un programma interamente costituito da musiche di colui, che già riconosciuto in vita maestro sommo, di eccelsa abilità contrappuntistica e di profonda potenza espressiva, meritò l’appellativo di «princeps musicae». La scelta si è indirizzata ai due ambiti portanti della vasta produzione palestriniana: la messa e il mottetto. Per la prima si è optato per la Missa «Jesu nostra redemptio», a quattro voci, facente parte del Missarum cum quatuor et quinque vocibus Liber Quartus pubblicato da Angelo Gardano a Venezia nel 1582. Una ristampa di questa raccolta si ebbe a Milano, per i tipi di Simone Tini, nel 1590. Per quanto è noto in Italia questa ristampa si trova completa di tutti e cinque i libri-parti soltanto in un esemplare conservato nel Fondo della Cappella Giulia della Biblioteca Apostolica Vaticana e nell’Archivio musicale del Duomo di Como.
Il Missarum Liber Quartus, che appare a distanza di dodici anni dalla precedente raccolta di messe, il Missarum Liber Tertius (Eredi di Valerio e Luigi Dorico, Roma, 1570), è dedicato da Palestrina a Gregorio XIII. La Missa «Jesu nostra redemptio» è una messa-parafrasi, ossia è composta sui motivi dell’omonimo inno gregoriano che un tempo era eseguito nella festa dell’Ascensione. Le quattro frasi che costituiscono la melodia originaria sono da Palestrina rimodellate in modi sempre diversi nel corso delle cinque parti dell’Ordinarium Missae (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) rimanendo però sempre perfettamente riconoscibili. Se è vero che i testi delle cinque parti della messa sono di per sé già fortemente strutturati è anche vero che la ripresa in ambito polifonico di motivi gregoriani – una tecnica ampiamente diffusa nel corso di tutto il Cinquecento e oltre accanto alla messa-parodia, che invece impiega e reinterpreta motivi e intere sezioni di preesistenti composizioni polifoniche sacre o profane – articola ulteriormente ed esalta quelle strutture testuali instaurando rimandi e simmetrie di tipo musicale, ma anche di natura testuale, che si attuano a più livelli.
La Missa «Jesu nostra redemptio», una delle più perfette sotto il profilo strutturale e formale fra l’imponente corpus delle 104 messe composte da Palestrina, è a questo proposito quanto mai significativa: le quattro frasi – motivi – dell’inno gregoriano sono distribuite così nell’ambito del Kyrie: «Kyrie I»/motivo 1, «Christe»/motivo 2, «Kyrie II»/motivi 3 e 4; nel Gloria gli stessi si susseguono senza soluzione di continuità nei primi quattro versetti, per poi comparire – solo alcuni di essi – qua e là nel prosieguo di questa parte della messa; nel Credo sono ripresi solo i motivi 2 – qua e là – e 4 (questo solo nel breve «et vitam venturi saeculi» finale); la tripartizione data al Sanctus – «Sanctus», «Benedictus», «Hosanna» – rende certamente più complessa la distribuzione dei motivi che Palestrina risolve magistralmente affidando alla prima sezione i primi tre motivi, alla seconda il quarto e alla terza il primo e il secondo. In questo modo egli isola maggiormente il «Benedictus» con il suo peculiare pathos espressivo – la lode tributata a Colui che viene riconosciuto come inviato da Dio – unitamente al fatto che questo passaggio è eseguito a tre voci; la ripresa dei primi due motivi nell’«Hosanna» da una parte chiude il cerchio dall’altra suona come qualcosa di ancora nuovo in virtù del fatto che questa sezione si svolge in metro ternario. Come spesso avviene nella messe polifoniche del XVI secolo, e in particolare in Palestrina, ci sono due Agnus Dei, il primo dei quali impiega i primi due motivi, il secondo, a sei voci, li impiega tutti e quattro nell’ambito di una eccelsa trama contrappuntistica intessuta intorno a un canone fra Tenor II e Altus I che procede con i quattro motivi dell’inno ripresi in successione e in forma di cantus firmus mentre le altre voci contrappuntano su quegli stessi motivi.
Si vede dunque come anche in questa messa, al pari di molte altre opere di Palestrina, il principio dell’unitas si fondi magnificamente a quello della varietas; ciò in conseguenza anche dal fatto che i motivi originali sono spesso contrappuntati da altri del tutto nuovi o, a volte, sono derivati da quelli, assumendo quindi valenza e configurazione autonoma, secondo una tecnica tipica di Palestrina per la quale un motivo può nascere da un altro in base a un processo che potremmo definire «per germinazione».
L’esecuzione della Missa «Jesu nostra redemptio» è preceduta dall’esecuzione dell’inno gregoriano dalla quale deriva e dell’omonimo inno polifonico, in alternatim, dello stesso Palestrina. Nell’uno e nell’altro caso viene riproposta la versione melodica in uso al tempo di Palestrina riportata da Giovanni Matteo Asola, Canto fermo sopra messe himni et altre cose ecclesiastiche appartenenti à sonatori d’organo per giustamente rispondere al choro (Giacomo Vincenti, Venezia, 1592, più volte ristampato fino agli anni Venti del Seicento) trascritta da Lorenzo Taroni, allievo del biennio di Composizione del Conservatorio «G. Verdi» di Como ed ex allievo del corso di Semiografia della musica antica. La pratica dell’alternatim, molto diffusa in passato, consisteva, fra le varie tipologie, anche nell’alternanza fra versetti in canto gregoriano e altri in polifonia, come in questo caso. L’inno palestriniano fa parte degli Hymni totius anni secundum Sanctae Romanae Ecclesiae consuetudinem […] quatuor vocibus concinendi pubblicati in due edizioni distinte, ma apparse entrambe nel 1589, l’una a Roma per opera di Giacomo Tornerio e Bernardo Donangelo (stampatore Francesco Coattino), l’altra, parziale, a Venezia per i tipi di Angelo Gardano. Palestrina dedica questa raccolta a Sisto V, pontefice particolarmente attento alla musica (a lui Costanzo Porta – entrambi erano francescani, dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, e furono in stretti rapporti –, dedicherà nel 1585 il Musica sex canenda vocibus liber tertius; nello stesso 1585, poco dopo essere stato eletto al soglio pontificio – fu uno dei suoi primissimi atti da pontefice –, Sisto V istituì ufficialmente la Compagnia dei Musici di Roma, sodalizio da cui sarebbe sorta, secoli dopo, l’Accademia Nazionale di S. Cecilia). Anche in questo caso la ripresa degli originali motivi in canto gregoriano avviene secondo il principio della varietas: spiccano il terzo versetto – «Inferni claustra penetrans» – nel quale la voce superiore esegue, uno dopo l’altro, i quattro motivi originali in cantus firmus, e il quinto versetto, a sei voci – «Tu esto nostrum gaudio», – caratterizzato, anche in questo caso, da un canone che si svolge fra Altus I e Tenor I ancora una volta sui quattro motivi dell’inno e di nuovo in cantus firmus.
Il mottetto O beata et gloriosa Trinitas (seconda parte, O vera summa et sempiterna Trinitas) fa parte del Liber Primus motettorum quae partim quinis, partim senis, partim septenis vocibus concinantur edito dagli eredi di Valerio e Luigi Dorico a Roma nel 1569. Palestrina dedica la raccolta al cardinale Ippolito II d’Este. Si tratta della prima raccolta mottettistica palestriniana contenente composizioni di questo genere a cinque voci. La luminosità dell’impianto modale di questa ampia composizione esalta plasticamente la solennità dell’immagine della Trinità. La ridondanza sonora data dall’impianto polivoco a cinque parti scaturisce anche dai diversi momenti dialogici fra gruppi di voci. Pochi elementi melodici ritornano continuamente variati nel corso della prima e della seconda parte del mottetto infondendo alla composizione una forte coesione. Notevole poi il modo nel quale Palestrina sbalza ogni volta l’immagine delle Tre Persone della Trinità mediante una perfetta fusione di momenti dialogici/timbrici differenziati e modulazioni ben mirate che se da un lato isolano momentaneamente ciascuna delle Persone dall’altra le legano l’una all’altra proprio mediante peculiari collegamenti armonici.
Diverso nell’impianto generale e nelle intenzioni espressive è il mottetto Salve regina (seconda parte, Eja ergo), brano inserito nel Motettorum quinque vocibus Liber Quintus pubblicato da Alessandro Gardano a Roma nel 1584. Destinatario di questa pubblicazione era il cardinale Andrzej Batory, nipote del re di Polonia Stefan Batory. Quindici anni separano le due raccolte mottettistiche qui prese in considerazione: se la prima esce pochi anni dopo la conclusione del Concilio di Trento (1545-1563) la seconda si pone negli anni della graduale – e non di rado problematica – applicazione di quelle norme e di quegli ideali propugnati dal Tridentino. Il mottetto Salve regina ben illustra i cambiamenti in atto: la ripresa di parti della melodia gregoriana originale si stagliano nella parte superiore della composizione e a livello generale il contrappunto imitato è più contenuto, ha meno spinte centrifughe; di contro maggior peso viene dato all’omofonia e, di conseguenza, a una maggiore nitidezza del testo cantato.
Si alternano ai brani del concerto quattro Ricercari della serie dei Ricercari sopra li otto toni attribuiti a Palestrina e trasmessi manoscritti (Roma, Biblioteca Corsiniana, ms. M14) fino alla loro prima pubblicazione avvenuta in tempi moderni. Sono composizioni strumentali a quattro parti, una per ogni modo ecclesiastico, redatte in partitura che presentano una scrittura densamente contrappuntistica; ogni brano presenta più motivi, talvolta anche combinando insieme due di questi. La moderna intavolatura per organo è stata realizzata da Lorenzo Casati, ex allievo del Conservatorio di Como.
In occasione del concerto odierno il pubblico potrà vedere da vicino, collocati in una vetrina, gli originali libri-parte del Missarum Liber Quartus di Palestrina nell’edizione del 1590 conservati nell’Archivio musicale del Duomo di Como. Si ringrazia l’archivista e organista del Duomo di Como, il Maestro Lorenzo Pestuggia, che ha reso possibile, in via eccezionale, l’uscita di queste preziose stampe dal luogo dove sono abitualmente conservate, e don Nicholas Negrini, direttore della Cappella Musicale del Duomo di Como, per aver provveduto all’idonea sistemazione delle stesse in modo da renderle fruibili al pubblico.
Michelangelo Gabbrielli